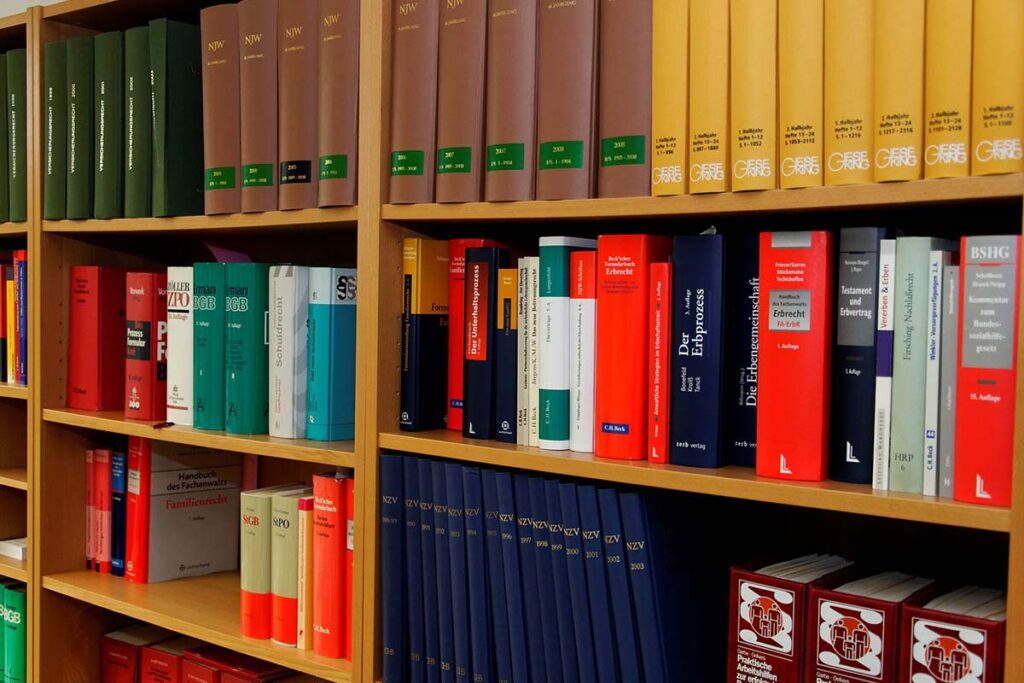Acque, sanzioni amministrative e ruolo delle Regioni: la sentenza del Consiglio di Stato n. 4687 del 29 maggio 2025
La vicenda giudiziaria che ha portato a questa significativa pronuncia ha origine in Abruzzo e coinvolge alcune società pubbliche “in house” che gestiscono il Servizio Idrico Integrato (SII) nella Regione. Queste società, responsabili di centinaia di impianti di depurazione di acque reflue urbane, si sono viste notificare nel 2021 oltre 50 sanzioni e ordinanze di ingiunzione di pagamento per presunte violazioni dell’articolo 133 del T.U.A. La particolarità e la gravità della situazione risiedevano nel fatto che le sanzioni irrogate erano fino a quasi 10 volte superiori al minimo edittale, una modulazione del tutto inusuale rispetto alla prassi precedente.
Le società appellanti hanno scoperto che alla base di queste ingiunzioni vi erano due determinazioni dirigenziali regionali, mai notificate o rese note prima: la Determinazione n. DPC017/313 del 28.10.2020 e la Determinazione n. DPC/263 del 23.12.2019. Queste determinazioni, secondo le società, avrebbero introdotto una disciplina autonoma e autoreferenziale sui metodi di calcolo e formule per aumentare il minimo edittale, in contrasto con l’articolo 11 della Legge 689/1981, che disciplina l’applicazione delle sanzioni amministrative e prevede una valutazione del caso concreto. Il punto cruciale del contenzioso era, quindi, la legittimità di tali atti amministrativi che, predeterminavano il quantum delle sanzioni, limitando drasticamente la discrezionalità dell’organo sanzionatore e violando, a detta delle ricorrenti, il principio di legalità e la riserva di legge.
Il TAR e i motivi di appello: un conflitto di interpretazioni
Il TAR Abruzzo, aveva respinto il ricorso delle società, ritenendo che le determinazioni dirigenziali si limitassero a fornire “coordinate ermeneutiche” per la determinazione della sanzione, senza introdurre parametri nuovi o eccentrici, e che avessero il solo scopo di uniformare l’applicazione delle sanzioni. Secondo il TAR, la determinazione della sanzione non sarebbe stata automatica ma “calibrata in base alle caratteristiche dell’accertamento svolto” e comunque “sempre quella prevista tra il limite minimo e massimo” dalla legge.
Le società hanno quindi presentato appello al Consiglio di Stato, basando le proprie argomentazioni su diversi e fondamentali motivi. Tra questi, spiccava la violazione degli Artt. 3, 23, 25, 97, 117 Cost. e Art. 7 CEDU, contestando l’arbitrarietà e l’irragionevolezza di criteri generali e astratti introdotti senza un adeguato potere normativo. Fondamentale era anche la questione della preclusione di conoscenza anteriore al fatto sanzionato, poiché le determinazioni, avendo natura regolamentare, avrebbero dovuto essere note prima dell’applicazione delle sanzioni. Si denunciava inoltre la violazione del Principio di Legalità e di Personalità della Pena, poiché i criteri matematici avrebbero escluso la necessaria discrezionalità. Infine, si contestava l’applicazione della reiterazione come aggravante, in assenza di una specifica previsione normativa statale, elemento che richiede sempre una riserva di legge.
Acque e sanzioni: la sentenza del Consiglio di Stato è un Chiarimento cruciale sul Potere Sanzionatorio
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformando la sentenza del TAR e annullando le determinazioni dirigenziali impugnate. Un esito che ha pienamente riconosciuto le ragioni delle società appellanti, fornendo al contempo un’interpretazione decisiva su principi fondamentali del diritto amministrativo e ambientale.
Il Collegio ha osservato che le determinazioni dirigenziali, lungi dal limitarsi a un mero indirizzo interno, avevano l’obiettivo esplicito di ridurre l’apprezzamento discrezionale dell’autorità competente alla determinazione della sanzione, introducendo “moltiplicatori”, “maggiorazioni e circostanze attenuanti” per ottenere una commisurazione priva di margini di apprezzamento. Questa impostazione, secondo il Consiglio di Stato, è incoerente con l’esegesi operata dalla Corte Costituzionale in materia di illeciti e sanzioni amministrative.
La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 5 del 2021) ha più volte ribadito che le garanzie dell’articolo 25, comma 2, della Costituzione (principio di legalità penale) si applicano anche alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo. Sebbene non sia richiesta una riserva assoluta di legge statale come per il diritto penale stricto sensu, resta ferma la riserva di legge relativa di cui all’articolo 23 Costituzione, intesa anche quale legge regionale. Ciò significa che la predeterminazione legislativa dei presupposti del potere sanzionatorio è un’esigenza imprescindibile, sia per la configurazione della norma di condotta che per la tipologia e il quantum della sanzione. Questo per assicurare al cittadino la tutela contro possibili abusi dell’autorità.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’esigenza di una “prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all’applicazione” delle sanzioni amministrative si ricollega al principio di imparzialità dell’amministrazione (Art. 97 Cost.) e alla riserva di legge dell’articolo 23 Costituzione. È l’organo legislativo – statale o regionale – che, rappresentando l’intero corpo sociale, deve predeterminare tali presupposti. Tale esigenza non può essere soddisfatta da un atto amministrativo, seppur generale. Anche laddove la legge rinvii a un atto amministrativo, la legge stessa deve definire i criteri direttivi per orientare la discrezionalità dell’amministrazione.
Competenza legislativa esclusiva statale e discrezionalità limitata
Un punto cruciale della sentenza riguarda la competenza legislativa. Le violazioni in materia di scarichi e tutela della qualità dei corpi idrici, disciplinate dall’articolo 133 del Testo Unico Ambientale, rientrano nella materia della tutela dell’ambiente, la cui competenza legislativa è esclusiva dello Stato. Sebbene l’articolo 135 del D.lgs. 152/2006 deleghi alle Regioni l’esercizio delle funzioni relative all’irrogazione delle sanzioni amministrative (nel rispetto della Legge 689/1981, limitatamente al procedimento applicativo), ne deriva che, per quanto concerne i criteri di determinazione delle sanzioni, le Regioni non dispongono di un autonomo potere normativo.
In virtù di ciò, il Consiglio di Stato ha concluso che le determinazioni dirigenziali abruzzesi, con la loro natura generale e astratta volta a specificare i parametri per la graduazione delle sanzioni pecuniarie, erano state adottate in carenza di potere. Spetta solo alla legge (statale, in questo caso) dettare i criteri per orientare l’esercizio della discrezionalità amministrativa in materia.
Inoltre, il Collegio ha rilevato che il meccanismo introdotto dal Dipartimento regionale finiva per creare un “rigido automatismo sanzionatorio“, impedendo di fatto di adattare la sanzione al caso concreto, così come invece prescritto dall’articolo 11 della Legge 689/1981. Quest’ultimo impone una personalizzazione della sanzione, tenendo conto di elementi quali la gravità della violazione, l’opera svolta dall’agente per eliminarne le conseguenze, la sua personalità e le sue condizioni economiche.
Acque e sanzioni: le implicazioni per la gestione ambientale e rifiuti
- Riaffermazione del principio di legalità: i criteri per determinare le sanzioni amministrative, soprattutto quelle punitive, devono essere stabiliti dalla legge e non possono essere introdotti con atti amministrativi di rango inferiore.
- Limiti alla discrezionalità amministrativa: la sentenza ribadisce che la discrezionalità nell’irrogazione delle sanzioni non può trasformarsi in arbitrio. Meccanismi di calcolo o formule che predeterminano rigidamente l’ammontare della sanzione, senza spazio per una valutazione del caso concreto, sono illegittimi.
- Chiarezza nelle competenze Stato-Regioni: viene marcato un confine netto tra le competenze legislative esclusive dello Stato (che definisce i criteri sanzionatori in materia ambientale) e le funzioni delegate alle Regioni (che riguardano il solo procedimento applicativo).
- Tutela del contribuente e giusto processo: la sentenza rafforza le garanzie per i soggetti sanzionati. La trasparenza e la conoscibilità preventiva dei criteri sanzionatori sono essenziali per consentire un’efficace difesa.
Ci auguriamo che questa sentenza contribuisca a promuovere un sistema sanzionatorio più equo, prevedibile e trasparente, in cui la repressione degli illeciti ambientali avvenga nel pieno rispetto dei principi di legalità e giustizia. Solo così si potrà garantire una tutela ambientale efficace, senza che la mano pubblica si trasformi in un arbitrio, ma rimanga un garante della legge e del bene comune.